
I giovani che sognano di diventare medico e affrontano il numero chiuso, l’università, la scuola di specializzazione e tutta la carriera in corsia, hanno ben chiare le idee di quella che sarà la loro vita quando muovono i primi passi in questa direzione? E perché scelgono di diventarlo? Per l’aura di prestigio che avvolge questa professione, per i soldi, per altruismo? Quella del medico non è una professione come le altre e se tanti sono apparentemente i risvolti positivi di una simile scelta di vita, altrettanti (se non superiori) sono quelli negativi.
«Chi indossa un camice da medico non se lo toglie mai. Quando scelsi di frequentare la facoltà di medicina mio zio, medico, mi disse: “Ricordati che studierai per tutta la vita”. E aveva ragione, il medico deve aggiornarsi continuamente…». Un avvertimento che Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia all’Università Statale di Milano, non ha mai dimenticato e che rappresenta solo una delle tante sfaccettature di una professione stimata e considerata fondamentale da tutti, ma molto spesso al centro di critiche e attacchi ingiustificati. Nucci ha riportato la propria esperienza personale (una lunga carriera in corsia e all’Università) nelle pagine di un libro dal titolo “Perché (non) fare il medico” (Piemme editore).
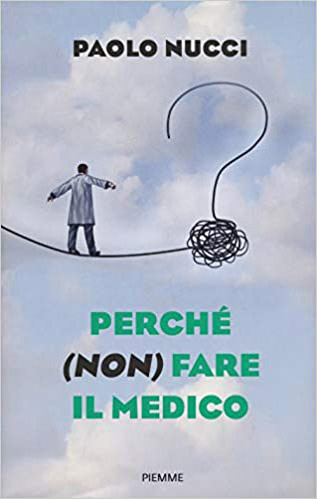 La vocazione
La vocazione«Chi decide di fare il medico lo fa perché sente di doverlo fare – spiega Nucci –. Per noi è una sorta di vocazione. Quando cominci a frequentare la facoltà di medicina sai sin dall’inizio che andrai a fare un’attività altruistica. È questa la molla che ti spinge, all’inizio. Certo, esiste anche un interesse legato alla figura del medico e alla sua collocazione sociale ed economica, inutile nasconderlo. È diventata una professione un po’ elitaria per via del numero chiuso e per la facilità di accesso al mondo del lavoro. Ma ai tempi miei questo non succedeva». A tal proposito: Nucci si è laureato nel 1983, a 23 anni. Cosentino di nascita ma napoletano di adozione (dove si è laureato in Medicina), ha frequentato la scuola di specializzazione a Trieste e dopo un anno si è trasferito al San Raffaele di Milano. Dopo vari giri all’estero, in particolare negli Stati Uniti, nel 2000 ha vinto il concorso come professore associato e dieci anni dopo è diventato primario nell’Ospedale San Giuseppe di Milano (incarico lasciato l’anno scorso). È stato anche Presidente della Società Italiana di Oculistica Pediatrica. Chi meglio di lui, insomma, per parlare dei pro e dei contro di questa professione?
«Una volta entrato a Medicina e cominciato a vedere quel mondo, capii che era devastante. Il professore lo vedevi solo in fotografia. Non erano guide come lo siamo noi oggi. Studiavi in una facoltà che ti considerava un estraneo e dopo la laurea venivi buttato in corsia dove ti veniva chiesto di lavorare tanto per sgravare gli altri del peso dei loro impegni. Facevi insomma parte di un sistema che non ti voleva».
Dall’ospedale come luogo in cui poter esprimere il proprio altruismo e la propria passione si passa dunque ad un ospedale visto come palestra: «Nei primi anni di lavoro sul campo si perde un po’ di quell’istinto primordiale che ti ha spinto a diventare medico e cominci a contare le esperienze che fai: il primo ago in vena, la prima incisione, eccetera». E questo è un passaggio molto delicato, perché il rischio è quello di cadere nel delirio di onnipotenza: «Il giovane medico è pericolosissimo: è convinto di star crescendo molto in fretta, di essere diventato presto molto bravo. Per questo a volte diventa arrogante. Ma questo non è altro che una manifestazione dell’effetto Dunning Kruger: meno si sa, più si crede di sapere». Questa crescita dell’ego viene stoppata dalle prime “bastonate”, come ad esempio «la prima causa medico-legale». È lì che il giovane «abbassa la cresta e ritorna anima e corpo nella professione». Ed è qui, però, che si nasconde un altro problema.
Più si va avanti nella carriera più aumentano le responsabilità, la consapevolezza del peso delle proprie azioni, i compiti sempre più complessi che vengono assegnati giorno per giorno, senza possibilità di fermarsi. E qui le possibilità sono due: «O diventi il malato immaginario che dice di non farcela più e si mette da parte perché non sta bene – spiega Nucci – oppure cadi nel burnout. Una sorta di esaurimento che ti fa disamorare della professione. Tutti questi passaggi non li ho inventati io, ovviamente, ma sono fasi della vita che ogni medico sperimenta, chi più chi meno». Ma come uscirne?
«Sono riuscito a riappacificarmi a 61 anni con la mia professione – spiega Nucci – non solo grazie alla riconoscenza dei pazienti, che comunque è fondamentale, ma anche a quella dell’allievo. Quando cominci a specchiarti in lui come fosse un figlio che hai creato tu. Quando fai un passaggio finale, in qualche modo catartico, in cui capisci che quello che hai fatto ha avuto un senso». Ed è qui che puoi pensare anche a farti da parte, visto che la tua eredità è in solide mani: «Sono convinto che il primario puoi farlo solo fino a 60 anni, poi si deve lasciare il posto a chi è più giovane». E su questo tema Nucci è molto netto: «Non sono affatto convinto che sia sano far diventare primario un professionista di 45 anni e lasciarlo in quella posizione per altri 25. Questa persona non solo non dà spazio ad altri, magari più capaci di lui, ma opera indisturbato, perché tanto sa che ci sarà sempre. Questo potere deve essere mitigato in qualche modo».
Oltre lo strapotere degli intoccabili primari, ci sono tre problemi di base che vanno affrontati per riuscire a sviluppare una sanità sana. Prima di tutto, il numero chiuso: «Il talento non cresce nelle scuole calcio blasonate ma nelle spiagge argentine dove sono cresciuti Maradona e tanti altri campioni. Il talento non viene fuori dalla grande università iperselettiva ma dalla quantità, purtroppo». Insomma, lasciare a tutti la possibilità di esprimersi e di emergere.
Altro elemento da modificare: «Le posizioni apicali non devono essere a vita ma devono avere una durata. Tornando all’esempio del primario, se questi sa che dopo un tot di anni, diciamo 7 o 10, dovrà farsi da parte e cercare un altro ospedale, questi cercherà di giocare al meglio le proprie carte per essere chiamato, una volta concluso il mandato, da qualche altra struttura. E più ha lavorato bene più la struttura che lo chiamerà sarà prestigiosa». Insomma, per restare nella metafora calcistica, come succede per gli allenatori: «Gli allenatori hanno un contratto a termine e più dimostrano di essere bravi maggiori possibilità avranno di essere ingaggiati da squadre di valore superiore».
Terzo errore, «grossolano e drammatico» e che si è palesato prepotentemente con la pandemia da Covid-19, «è il territorio. Quando nel 1978 abbiamo riformato il Servizio sanitario nazionale abbiamo preferito lasciar fuori i medici di Medicina Generale. Oggi sono liberi professionisti e lo stiamo pagando. Abbiamo snaturato il territorio e in quest’ottica ben vengano le case della salute in cui lavora un team di medici. È questa la salvezza della sanità».
Il libro, in realtà, non vuole dissuadere nessuno dall’intraprendere una carriera nel mondo sanitario ma chi decidere di incamminarsi in questo percorso «deve conoscere anche le cose negative». E, forse, vuole essere anche un grido di allarme: «Voi che non lo siete, lo sapete cosa vuol dire fare il medico? Sapete quali sono gli ostacoli che troviamo ogni giorno in questo percorso? Spesso la stampa cerca di trovare una notizia dietro un evento di malasanità, perché fa gioco. Ma il vissuto di un medico, anche di un professionista che ha commesso un errore, chi lo conosce, chi lo va ad indagare? Quando parlo di burnout in realtà dico: “Attenzione, ci stiamo esaurendo”. Ed arriva il momento in cui ci si chiede: “Per cosa lo faccio, perché continuo? Per me o per il paziente?”. Il medico è una persona che va aiutata perché solo così lui potrà aiutarvi. Dobbiamo interiorizzare come comunità il concetto che medici e pazienti non sono e non possono essere nemici. La medicina difensiva è la manifestazione del terrore di alcuni di noi di essere denunciati se qualcosa non va per il verso giusto. Se non lo capiamo tutti – conclude Nucci –, le liste di attesa saranno sempre più lunghe e accadrà ciò che succede in America, in cui un medico può dire “I am not comfortable with this», ovvero “non sono a mio agio in questa situazione”, e quindi rifiutarsi di curare un determinato paziente. In questa situazione, il paziente pellegrinerà di medico in medico fino a quando non ne troverà uno, ovvero quello che deve fare esperienza. E questo è un tipo di sanità che andrà sempre, sempre peggiorando».
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato
 Articoli correlati
Articoli correlati